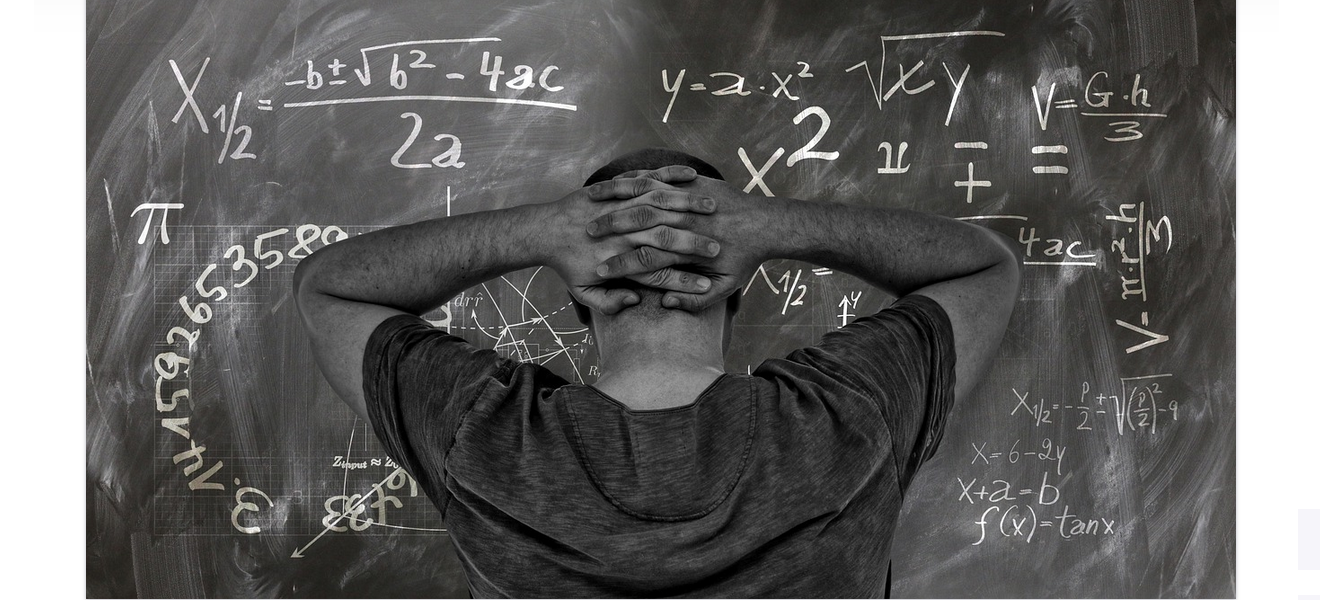di Anastasia Palma
Sommario
-
Premessa
-
L’autonomia universitaria come sistema
-
La responsabilità disciplinare del personale tecnico-amministrativo
-
La peculiarità del regime disciplinare dei docenti universitari
-
Responsabilità disciplinare e procedimento penale
-
Pregiudizialità penale e sospensione cautelare
-
Premessa
L’esclusione del rapporto di impiego dei docenti universitari dalla contrattualizzazione del pubblico impiego, con conseguente sottrazione del settore alle norme del T.U.P.I. (d. lgs. N. 165 del 2001 e successive modifiche e integrazioni), culminata nella cd. Riforma Gelmini (l. n. 240 del 2010), ha determinato il prodursi di un peculiare assetto normativo in materia di responsabilità disciplinare. Si è innovato per quanto attiene a competenza degli organi e aspetti procedurali, lasciando inalterato il precedente quadro normativo per gli aspetti sostanziali degli illeciti e delle sanzioni disciplinari.
Le principali novità si rinvengono nel decentramento del potere disciplinare presso le singole Università e nell’attribuzione della potestà di irrogare la sanzione disciplinare al Consiglio di amministrazione, lasciando al Rettore solo il potere di comminare la censura, come portato del complessivo ius superveniens che ha introdotto l’autonomia universitaria, in virtù della quale, pur essendo rimasto immutato il catalogo delle sanzioni previste dal previgente T.U. del 1933, cui fa espresso rinvio l’art. 10, comma 2, l. n. 240 del 2010, si è devoluto ai singoli Atenei il potere sanzionatorio, prima attribuito al C.U.N. a livello nazionale.
- L’autonomia universitaria come sistema
Il termine autonomia viene utilizzato frequentemente nel linguaggio giuridico assumendo, spesso, un significato generico, ossia quello della situazione di una persona o una cosa che gode di una certa libertà o facoltà di movimento relativamente ad altra persona o ad altra cosa. In realtà tale termine ha origine filosofico-giuridica passando dal diritto al vocabolario non giuridico, assumendo significati di genere piuttosto che di specie. Tra i diversi concetti di autonomia, quello per antonomasia è il concetto di autonomia normativa che dovrebbe indicare la situazione di chi impartisce a se stesso le norme giuridiche, quindi del soggetto giuridico che trovando la fonte delle proprie norme in sé e non in altri agisce secondo tali norme. In tal senso, nell’ordine esistente, sono soggetti dotati di autonomia le comunità ed enti esponenziali di ordinamenti generali sovrani, quindi nazioni, Stati, imperi, polis. La definizione più corretta di autonomia è quella di potestà attribuita in ordinamenti giuridici statali ad enti diversi dallo Stato di emanare norme costitutive dello stesso ordinamento giuridico statale. I soggetti ai quali generalmente viene attribuita autonomia normativa sono gli enti pubblici. Lo Stato, nel conferire tale potestà obbedisce a regole di opportunità, a prescindere dalla natura dei soggetti e delle loro funzioni. Varia sia il criterio di distribuzione che la misura della stessa. Infatti vi sono enti territoriali che hanno un’ampia autonomia normativa, mentre in altri l’autonomia si circoscrive al regolamento organico del personale, poi tra questi due estremi vi sono anche figure intermedie. Pertanto, il senso corretto da attribuire al concetto di autonomia normativa è il seguente: norme che promanano dai soggetti investiti di tale potestà regolano gli interessi curati dai medesimi soggetti. Tali interessi, a seconda delle particolari regole del diritto positivo, coincideranno in tutto o in parte con quelli dello Stato, ma la loro regolazione è affidata non a quest’ultimo, al soggetto che li cura. L’autonomia normativa è intesa, sotto tale aspetto, come indipendenza di regolazione normativa. Il soggetto avente autonomia normativa possiede la potestà di regolare interessi, propri e dello Stato, con norme proprie che integrano quelle statali e ad esse sono equiparate. Da ciò si deduce che nell’ambito dell’ordinamento statale varia il grado di integrazione (degli atti) e delle norme di autonomia1.
Il concetto di autonomia è stato al centro di un processo normativo che ha interessato l’istituzione universitaria. Molti Paesi europei hanno riorganizzato il proprio sistema di istruzione superiore. Il Consiglio d’Europa, nell’ambito delle Considerations and Recommendations (22-23 settembre 2005) ha evidenziato come i sistemi universitari non possano raggiungere pregevoli livelli qualitativi senza una <<good governance>>fornendo precise indicazioni per realizzarla quali: la garanzia dell’autonomia istituzionale, la previsione di meccanismi volti ad assicurare l’accountability dei soggetti inseriti nell’articolazione dell’Università e la partecipazione degli stakeholders. Nei tratti essenziali, il fondamento del nuovo modello di governance si basa sulla concessione dell’autonomia all’Università affinché le stesse possano adottare modelli efficaci, competere tra loro ed essere sottoposte a valutazione. Con riferimento al nostro ordinamento giuridico, dall’art. 33 della Costituzione è possibile estrapolare il grado di autonomia concesso ai diversi livelli di governo che intervengono con riguardo ai sistemi universitari e più specificamente nei singoli Atenei. Il sesto comma sancisce che <<Le istituzioni di alta cultura, università e accademie hanno diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato>>. La norma, almeno fino all’approvazione della l. n. 168 del 1989 è stata intesa come riconoscimento in capo alle università di un potere di autogoverno, in termini di definizione di regole per il proprio funzionamento e la propria organizzazione interna, nei limiti delineati dalla legislazione statale. In stretto collegamento con il primo comma dell’articolo 33 Cost., l’autonomia sancita al sesto comma è stata intesa come funzionale rispetto alla comunità universitaria. Una prima tappa del processo di autonomia è data dalla l. n. 168 del 1989 rubricata <<Istituzione del Ministero dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica>> che ha previsto in capo alle Università specifici ambiti di autonomia normativa da realizzarsi attraverso l’attribuzione agli statuti, del potere di disciplinare una serie di materie, oltre all’autonomia contabile e finanziaria dei singoli Atenei. Gli stessi statuti, con riguardo alla governance dell’Ateneo, dovevano disporre l’elettività del Rettore, oltre che stabilire una dettagliata e precisa composizione del Senato Accademico che fosse rappresentativa di tutte le Facoltà e del Consiglio di amministrazione nel senso della rappresentanza delle diverse componenti universitarie. Specificamente, l’articolo 6 di tale legge, rubricato <<Autonomia delle Università>> ha delineato la portata di tale autonomia delle Università, stabilendo come esse dovessero disporre di <<autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile>>. Con questa legge, è stato riconosciuto non solo un potere statutario in capo alle Università, ma è stato avviato un processo di progressiva concessione di autonomia alle stesse con contestuale riorganizzazione di tutto il sistema, anche a livello centrale e l’assetto istituzionale centrale, quindi il Ministero, avrebbe dovuto mutare il proprio ruolo attuando il passaggio da organo di comando e controllo, ad organo di indirizzo e programmazione e valutazione della performance dell’Università. Le riforme che si sono succedute, hanno ampliato l’autonomia degli Atenei, realizzando degli interventi settoriali volti a garantire una maggiore autonomia alle Università e ad attuare un accentramento del potere decisionale in capo al Ministero, nella materia finanziaria e di allocazione dei fondi. Il percorso di riforma del sistema interno di governance universitario è culminato nella l. del 30 dicembre 2010 n. 240 rubricata <<Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario>> meglio nota come <<riforma Gelmini>> i cui tratti essenziali si rinvengono nel disporre una riorganizzazione del sistema universitario italiano, con l’obiettivo di perseguire la principale finalità di promozione dell’efficienza, in un’ottica di sostenibilità economica e promozione del merito. Tale riforma, inoltre, ha definito la revisione di alcuni aspetti organizzativi e funzionali con riferimento all’ambito universitario, incidendo sulla didattica, sul reclutamento e meccanismi premiali di finanziamento tesi all’incremento della qualità. Essa ha coinvolto i principali meccanismi di funzionamento delle Università all’esito di un percorso determinato da stratificazioni normative su leggi datate durato anni e l’affermazione dell’autonomia in capo alle Università è stata accompagnata da una specifica definizione degli organi necessari per la governance di Ateneo. La previsione è che il Rettore sia eletto tra i professori ordinari in servizio presso le Università italiane con mandato di sei anni non rinnovabile e con funzioni di rappresentanza legale dell’università; indirizzo; iniziativa e coordinamento delle attività sia scientifiche che didattiche; previsione della responsabilità del conseguimento delle finalità dell’università in base a criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia, trasparenza, promozione del merito e qualsiasi altra funzione non espressamente attribuite dallo statuto ad altri organi dell’Università.
Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero massimo di undici componenti aventi competenze gestionali ovvero un’elevata esperienza professionale almeno tre dei quali (nell’ipotesi in cui il Consiglio di Amministrazione sia composto da undici membri) oppure due (nel caso in cui esso sia composto da un numero di membri inferiore ad undici) devono essere soggetti esterni all’Ateneo, a decorrere dai tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell’incarico. Le funzioni di tale organo sono state ampliate: tra le principali si evidenziano quelle di indirizzo strategico; approvazione finanziaria annuale e triennale e del personale e funzioni di vigilanza sulla sostenibilità finanziaria delle attività. Inoltre, esso deve adottare il regolamento di amministrazione e contabilità e su proposta del Rettore, previo parere del Senato Accademico, per gli ambiti che rientrano nella sua competenza, ha la competenza relativa all’approvazione di tutti i documenti contabili rilevanti per l’Università. In ordine alla competenza sull’attivazione e soppressione di corsi e sedi, previo parere del Senato Accademico, esercita un’influenza diretta sugli ambiti che riguardano la ricerca e la didattica.
Se la riforma Gelmini ha potenziato il ruolo del Rettore e del Consiglio di Amministrazione ha invece ridimensionato il ruolo del Senato Accademico, organo costituito su base elettiva che rappresenta gli esponenti della comunità accademica e che ha funzioni di proposta e consultive per quanto riguarda la didattica; la ricerca; i servizi agli studenti; attivazione modifica o soppressione di corsi, sedi, dipartimenti e nuove strutture di raccordo tra questi; poteri deliberativi propri sull’approvazione del regolamento di Ateneo e previo parere del Consiglio di Amministrazione, degli altri regolamenti, ad eccezione di quello di amministrazione e contabilità che rientra nella competenza di quest’ultimo. Possiede competenze di coordinamento e raccordo con i Dipartimenti, anche in virtù della presenza in seno all’organo di cui trattasi, di una quota dei relativi Direttori. Ha la possibilità di proporre al corpo elettorale, con maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, una mozione di sfiducia al Rettore, non prima dei due anni dall’inizio del suo mandato2.
- La responsabilità disciplinare del personale tecnico-amministrativo
A seguito della contrattualizzazione del pubblico impiego, l’art. 2 del d. lgs. n. 165 del 2001 riafferma il primato delle disposizioni del Codice civile e della contrattazione collettiva e individuale come fonti della disciplina dei rapporti dei dipendenti della pubblica amministrazione, salve le disposizioni contenute nello stesso decreto. Permane, nonostante sia venuto meno l’assetto pubblicistico del rapporto di impiego, il perseguimento del pubblico interesse da parte dell’azione amministrativa (così come ribadito dall’articolo 5, comma 1, d. lgs. n. 165 del 2001). Ciò comporta rilevanti deroghe alla disciplina del rapporto subordinato nell’impresa come ad esempio la costituzione del rapporto, l’esercizio dello ius variandi e del potere disciplinare. Dal personale contrattualizzato è bene differenziare le categorie di personale di pubblico impiego elencate nell’articolo 3 del d. lgs. n. 165 del 2001 (che ha recepito il testo dell’articolo 2, commi 4 e 5 del d. lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche) che sottratte alla contrattualizzazione, restano assoggettate alla disciplina di diritto pubblico. Si tratta di magistrati, avvocati e procuratori dello Stato, del personale militare e delle forze della polizia dello Stato, dei dipendenti della Banca d’Italia e della Consob, dell’Autorità Garante della concorrenza e del mercato, del personale della carriera diplomatica, dei professori e ricercatori universitari. Con riferimento alla materia disciplinare, il procedimento disciplinare è regolato dagli artt. 55 e ss. del d. lgs. n. 165 del 2001, nel testo che risulta dalle modifiche adottate, da ultimo, dal d. lgs. n. 75 del 2017 (che ha attuato la riforma Madia) attraverso cui si è proceduto a rafforzare il potere sanzionatorio delle pubbliche amministrazioni. All’articolo 12 del d. lgs. n. 75 del 2017 è previsto, infatti, che la violazione delle disposizioni in materia di procedimento e sanzioni disciplinari costituisce a sua volta illecito disciplinare in capo ai dipendenti tenuti alla loro applicazione. Analogamente al settore privato, anche qui trova applicazione l’articolo 2106 c.c. rubricato <<sanzioni disciplinari>> secondo cui <<L’inosservanza delle disposizioni contenute nei due articoli precedenti può dar luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari, secondo la gravità dell’infrazione>>. Il riferimento è agli articoli 2105 e 2106 c.c. che sanciscono gli obblighi di diligenza e fedeltà a carico del prestatore di lavoro durante lo svolgimento del rapporto lavorativo. Pertanto, la competenza, nel pubblico impiego contrattualizzato, a regolare la tipologia delle infrazioni e in ordine alla previsione delle relative sanzioni è in capo alla contrattazione collettiva. L’articolo 63 comma 2 bis, introdotto dall’articolo 21 del d. lgs. n. 75 del 2017, prevede che nell’ipotesi di annullamento della sanzione disciplinare per difetto di proporzionalità, il giudice possa rideterminare la sanzione, in applicazione delle disposizioni contrattuali e normative vigenti e in relazione alla gravità del comportamento e dell’interesse pubblico violato. Il codice disciplinare viene pubblicato sul sito istituzionale della pubblica amministrazione ed equivale alla previsione vigente nel settore privato che vede l’affissione del codice disciplinare all’ingresso della sede di lavoro. Differenza rilevante rispetto il settore privato è che nel pubblico impego contrattualizzato l’esercizio del potere disciplinare è obbligatorio, ad eccezione di giustificato motivo. Infatti, il dirigente responsabile è chiamato, a seconda dei casi, a procedere egli stesso all’avvio del procedimento o ad inoltrare la segnalazione all’ufficio disciplinare competente. La sua ingiustificata inerzia o il ritardo viene a sua volta sanzionata e valutata anche ai fini della responsabilità dirigenziale, così come previsto dall’art. 55- sexies, comma 3 del d. lgs. n. 165 del 2001.
L’articolo 55-bis del d. lgs. n. 165 del 2001, così come modificato dall’articolo 13 del d.lgs. n. 75 del 2017, disciplina la forma e i termini del procedimento disciplinare. Se si tratta di sanzioni non superiori al rimprovero verbale può procedere direttamente il responsabile della struttura presso cui lavora il dipendente. Per le sanzioni più gravi può essere individuato un ufficio per i procedimenti disciplinari ad hoc. Il procedimento inizia con la segnalazione immediata, che deve essere effettuata entro dieci giorni dal fatto, del responsabile della struttura presso cui presta servizio il pubblico dipendente, all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari in relazione ai fatti disciplinarmente rilevanti di cui abbia avuto conoscenza. Il procedimento disciplinare deve concludersi entro novanta giorni dalla contestazione dell’addebito. La contestazione può avvenire anche mediante posta elettronica certificata, così come tutte le successive comunicazioni possono avvenire mediante strumenti informatici. L’art. 55-bis, comma 9 ter del d.lgs. n. 165 del 2001 introdotto dal d. lgs. n. 75 del 2017 stabilisce che la violazione dei termini e delle disposizioni previste dalla materia disciplinare, ad eccezione della responsabilità eventuale del dipendente che ne risulti responsabile, non determina né la decadenza dell’azione, né l’invalidità della sanzione, purché non risulti compresso in modo irreparabile il diritto di difesa del dipendente e sussista una compatibilità tra le modalità di esercizio dell’azione disciplinare e il principio di tempestività. Inoltre, secondo l’articolo 55-bis comma, comma 9 quater del d.lgs. n. 165 del 2001 introdotto dal d.lgs. n. 75 del 2017, nell’ipotesi di annullamento della sanzione, compreso il licenziamento, per violazione del principio di proporzionalità, è prevista la possibilità che la pubblica amministrazione possa riaprire il procedimento disciplinare, con conseguente nuova decorrenza dei termini. Il d. lgs. n. 75 del 2017 ha modificato l’art. 55-quater del d. lgs. n. 165 del 2001 arricchendo le ipotesi di sanzioni che comportano il licenziamento disciplinare. Infine, ulteriore caratteristica del procedimento disciplinare previsto nel settore pubblico è il c.d. patteggiamento disciplinare cioè la possibilità di concordare nell’ambito di procedure di conciliazione stabilite dai contratti collettivi una sanzione ridotta e non impugnabile, a patto che sia della stessa specie di quella prevista così come sancito dall’articolo 55, comma 33.
- La peculiarità del regime disciplinare dei docenti universitari
Il tema della responsabilità disciplinare assume connotati peculiari proprio con riferimento alle categorie del personale di pubblico impiego elencate dal citato art. 3 del d. lgs. n. 165 del 2001 che restano regolate dalla disciplina pubblicistica. Le fonti che disciplinano la materia si rinvengono, in via generale nel d.p.r. 10 gennaio 1957 n. 3 (testo unico degli impiegati civili dello Stato) ed in altre fonti unilaterali, sia legislative che regolamentari che si riferiscono alle singole categorie di dipendenti. In materia di procedimento disciplinare, la principale fonte normativa per il personale in regime di diritto pubblico è costituita dal testo unico che garantisce autorità alla pubblica amministrazione. L’assoggettamento al regime di diritto pubblico determina che il provvedimento che applica la sanzione disciplinare si configuri come atto autoritativo con la previsione di una specifica e dettagliata motivazione, che anche alla luce di quanto disposto dall’art. 3 della l. n. 241 del 1990 (motivazione del provvedimento), illustri i presupposti di fatto e le ragioni della decisione. Quindi ai procedimenti disciplinari che riguardano le categorie di personale in regime di diritto pubblico, si applicano le norme del testo unico che integrano importanti garanzie quali l’osservanza del principio del contraddittorio, l’audizione dell’interessato e la contestazione dell’addebito. Al procedimento disciplinare si applicano inoltre alcune disposizioni previste dalla l. n. 241 del 1990 e precisamente gli articoli 7 (comunicazione di avvio del procedimento), 10 e 11 (che regolano il diritto di accesso). Altra conseguenza derivante dall’assoggettamento al regime pubblicistico del rapporto di lavoro, è data dalla devoluzione delle relative controversie alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (art. 63 comma 4, del d. lgs. n. 165 del 2001 e art. 133 comma 1 lett. i) del d.lgs. n. 104 del 2010) e la possibilità di proporre impugnazione secondo i paramenti di legittimità del provvedimento amministrativo, ossia per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere.
Fino al 2006, il quadro normativo relativo al procedimento disciplinare dei docenti universitari (in tale categoria si ricomprendono professori e ricercatori universitari così come previsto dall’articolo 10, comma 3 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 che ha per ultima regolamentato il regime disciplinare dei docenti universitari) era costituito dall’articolo 12 della legge 18 marzo 1958 n. 311 rubricata <<Norme sullo stato giuridico ed economico dei professori universitari>> e dalle disposizioni di cui agli artt. 87, 88, 89, 90 e 91 del testo unico delle leggi sull’istruzione superiore (r.d. 31agosto 1933, n. 1592) e 85, 91, 96, 97 e 98 del d.p.r. n. 3 del 1957, purché compatibili con le norme del citato testo unico cui l’articolo 12 faceva rinvio. Questa regolamentazione risulta attualmente in parte ancora in vigore, nonostante le modifiche introdotte con la l. 16 gennaio 2006 n. 18 rubricata <<Riordino del Consiglio Universitario nazionale>> e in ultimo la l. n. 240 del 2010.
La l. n. 18 del 2006 aveva inserito talune novità in ambito disciplinare, attribuendo al Collegio di disciplina composto da cinque membri del Consiglio universitario nazionale la funzione di svolgere i procedimenti disciplinari a carico dei professori e ricercatori universitari. L’azione disciplinare davanti al Collegio di disciplina era di competenza del Rettore alla fine di un’istruttoria attinente ad ogni fatto che potesse dar luogo all’irrogazione di una sanzione più grave della censura, tra quelle previste dall’articolo 87 del T.U. delle leggi sull’istruzione superiore di cui al R.D. 31 agosto 1933, n. 1952, entro trenta giorni dalla conoscenza dei fatti. Il Rettore competente, così, procedeva all’irrogazione della sanzione, previo parere favorevole del Collegio ed entro trenta giorni dalla sua ricezione. L’estinzione del procedimento disciplinare avveniva in caso di mancata pronuncia del Collegio di disciplina entro centottanta giorni dalla data di ricezione degli atti trasmessi al Rettore.
Con l’entrata in vigore di questa legge non era stato abrogato il previgente regime disciplinare regolato dalla l. 311 del 1958. L’assenza di una regolamentazione espressa dei rapporti tra le due fonti normative aveva determinato come conseguenza l’esigenza di coordinare di volta in volta le diverse disposizioni.
L’articolo 10 della l. n. 240 del 2010 (si tratta della legge di riforma del sistema universitario, c.d. riforma Gelmini, recante norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e di reclutamento) ha introdotto nuove modifiche al regime disciplinare dei docenti universitari abrogando l’articolo 3 della l. n. 18 del 2006 e prevedendo l’istituzione, presso ciascuna Università ed in base a modalità previste dallo statuto, di un Collegio di disciplina composto in via esclusiva da professori e ricercatori a tempo indeterminato in regime di tempo pieno (per gli aspetti non espressamente disciplinati da tale articolo producono effetti i rinvii normativi previsti dall’articolo 12 della l. n. 311 del 1958). Inoltre, accanto a tale normativa specifica, trovano applicazione al procedimento disciplinare dei docenti universitari le disposizioni della l. n. 19 del 7 febbraio del 1990 rubricata <<Modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti>> e quelle della l. n. 97 del 27 marzo 2001 rubricata <<Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche>>.
I provvedimenti disciplinari applicabili ai docenti universitari, in virtù del rinvio previsto dall’articolo 10, comma 2 della l. n. 240 del 2010, sono quelli disciplinati dall’articolo 87 del r.d. n. 1933 del 1952.Tale norma elenca le seguenti sanzioni, in base ad un principio di gradualità: la censura nelle ipotesi di mancanza di doveri di ufficio o di condotta irregolare che non costituisca insubordinazione; la sospensione dall’ufficio e dallo stipendio fino ad un anno che si applica nei casi di grave insubordinazione, abituale mancanza ai doveri d’ufficio, abituale irregolarità della condotta ed altri atti in genere che ledano la dignità o l’onore del professore (art. 89, comma 1, r.d. n. 1952 del 1933) e le sanzioni espulsive della revocazione e della destituzione senza perdita del diritto a pensione o assegni che si applicano ai comportamenti elencati con riferimento alla sanzione della sospensione quando siano caratterizzati da maggiore gravità. La destituzione con perdita di diritto alla pensione o ad assegni sancita dall’articolo 87 r. d. n. 1952 del 1933 non può essere applicata a seguito dell’abrogazione, prevista dall’art. 1 della l. n. 424 dell’8 giugno 1966 rubricata <<Abrogazione di norme che prevedono la perdita, la riduzione o la sospensione delle pensioni a carico dello Stato o di altro ente pubblico>> di tutte le disposizioni che determinano, successivamente ad una condanna penale o provvedimento disciplinare, la riduzione o la sospensione del diritto dei pubblici dipendenti al raggiungimento della pensione e di qualsiasi altro assegno o indennità da liquidarsi conseguentemente alla cessazione del rapporto di lavoro. Inoltre, dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 971 del 14 ottobre 1988 e dagli artt. 9, comma 1 l. n. 19 del 1990 rubricata <<Modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti>> e 5, comma 4 della l. n. 97 del 2001 rubricata <<Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche>> si evince, con riferimento alla sanzioni disciplinari della revocazione e dalla destituzione, il divieto di automatismi espulsivi. Queste sanzioni espulsive, quindi devono essere applicate al termine del procedimento disciplinare e con l’osservanza del principio di proporzionalità sanzionatoria. Si rileva, inoltre, come il sistema disciplinare della docenza universitaria, sia caratterizzato, con riferimento alla determinazione delle fattispecie disciplinari, da una particolare elasticità in quanto sono previste solo alcune clausole generali come la grave insubordinazione, l’abituale mancanza ai doveri d’ufficio, l’abituale irregolarità di condotta o la stessa definizione di atti che comunque ledano la dignità e l’onore del professore. Sussiste una netta differenza rispetto ai codici disciplinari del pubblico impiego privatizzato, caratterizzati invece da una tassativa predeterminazione delle condotte sanzionabili.
L’articolazione del procedimento disciplinare è delineata nell’art. 10 della l. n. 240 del 2010 rubricato <<competenza disciplinare>>. La fase iniziale è di competenza del Rettore che avvia il procedimento (si evidenzia come anche precedentemente, l’abrogato art. 3 della l. n. 18 del 16 gennaio 2006 affidava al Rettore la competenza in merito all’istruttoria disciplinare e le funzioni di relatore innanzi al Collegio di Disciplina). Per ogni fatto che possa dar luogo all’applicazione di una sanzione più grave della censura, il Rettore trasmette gli atti al collegio di disciplina nel termine di trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, formulando una proposta motivata così come sancito dall’art. 10, comma 2, della l. n. 240 del 2010. Anche nel procedimento disciplinare dei docenti universitari vige il principio dell’obbligatorietà dell’azione disciplinare che caratterizza il sistema del lavoro pubblico. L’esercizio del potere disciplinare da parte del Rettore è preceduto da una preventiva istruttoria, che deve essere effettuata nell’arco di tempo di trenta giorni dalla conoscenza dei fatti così come previsto dall’art. 10, comma 2, della citata legge, ed è finalizzata a verificare l’attendibilità degli elementi di fatto connessi all’esercizio del potere disciplinare. Ultimata l’istruttoria, si procede alla contestazione degli addebiti all’incolpato e viene stabilito un termine per la presentazione delle deduzioni. Tuttavia non risulta del tutto chiaro se la contestazione degli addebiti prevista dall’art. 89, comma 6, del r.d. n. 1592, debba essere effettuata in sede istruttoria preliminare o nella fase davanti al Collegio di disciplina. Il procedimento disciplinare dinnanzi al Collegio di disciplina si svolge nel rispetto del principi del giudizio tra pari e del contraddittorio e vengono ascoltati il Rettore ovvero un suo delegato, nonché il professore o il ricercatore sottoposto al procedimento disciplinare, eventualmente affiancato da un difensore di fiducia. Il Collegio di disciplina, sulla proposta avanzata dal Rettore, nel termine di trenta giorni esprime un parere <<sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare, sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare e trasmette gli atti al consiglio di amministrazione per l’assunzione delle conseguenti deliberazioni>> (art. 10, comma 3, l. n. 240 del 2010). La competenza in ordine all’adozione della sanzione o all’archiviazione del procedimento è devoluta al Consiglio di amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti, che provvede nel termine di trenta giorni dalla ricezione del parere, conformemente al parere vincolante espresso dal Collegio di disciplina. L’estinzione del procedimento si verifica nel caso in cui la decisione in relazione all’inflizione della sanzione o all’archiviazione del procedimento, non avvenga nell’arco di tempo di centottanta giorni dalla data di trasmissione degli atti al Consiglio di amministrazione. Questo termine è sospeso nelle ipotesi di ricostituzione del Collegio di disciplina ovvero del Consiglio di amministrazione quando siano in corso delle operazioni predisposte alla formazione dello stesso che ne impediscano il regolare funzionamento. Un altro caso di sospensione si verifica quando il Collegio di disciplina ritenga, per ragioni istruttorie, di dover acquisire ulteriori atti e documenti. In questi casi il Rettore deve dare esecuzione alle richieste istruttorie che possano essere avanzate dal Collegio per non più di due volte, e determinano, per ciascuna volta, una sospensione del termine per un arco di tempo non superiore ai sessanta giorni. Nella procedura disciplinare delineata dall’art. 10 della l. n. 240 del 2010, che si svolge in sede collegiale davanti al Collegio di disciplina, il Rettore è investito del ruolo dell’accusa, l’incolpato svolge il ruolo della difesa ed il Collegio di disciplina svolge la funzione di giudicante. Ulteriore novità introdotta dalla l. n. 240 del 2010 riguarda il decentramento presso ciascuna università del Collegio di disciplina (a differenza di quanto stabilito dall’art. 3 della l n. 18 del 2006 che prevedeva l’istituzione del Collegio di disciplina presso il Consiglio Universitario Nazionale). Altro aspetto innovativo attuato dalla citata legge è l’attribuzione in capo al Consiglio di amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti, della potestà di applicare la sanzione disciplinare finale (nel previgente sistema la competenza era in capo al Rettore). Si rileva inoltre che la l. n. 240 del 2010 lasci ampia discrezionalità all’azione disciplinare dei Rettori, derivante anche dalla flessibilità del sistema disciplinare dei docenti universitari collegata alla mancanza di una specifica individuazione dei comportamenti che possono essere sanzionati disciplinarmente.
-
Responsabilità disciplinare e procedimento penale
Sul rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale e sugli effetti del giudicato penale nel rapporto di lavoro della pubblica amministrazione ha inciso profondamente la l. n. 97 del 2001 che ha inserito varie norme volte a disciplinare i profili di responsabilità dell’impiegato pubblico con riferimento sia al giudizio penale conseguente agli illeciti, sia agli aspetti di tipo disciplinare. Tale legge prevede dei collegamenti tra procedimento penale e procedimento disciplinare molto meno rigidi rispetto a leggi passate, (in particolare il d.p.r. n. 3 del 1957 e la l. 19 marzo 1990 n. 55) recependo, così, l’orientamento della Corte Costituzionale la quale nel periodo precedente all’emanazione della citata legge e con diverse pronunce aveva delineato i limiti e l’ambito del giudicato penale sul procedimento disciplinare. La Corte Costituzionale ha censurato i numerosi tentativi del legislatore finalizzati ad introdurre automatismi per la produzione di effetti diretti del giudicato penale o più semplicemente del procedimento penale sul rapporto di lavoro. Sul punto, essa ha più volte dichiarato non conformi alla Costituzione quelle norme che stabilivano decadenze o destituzioni di diritto, senza la previsione di un’autonoma rivalutazione in sede disciplinare dei fatti di rilevanza penale. Esempi di tali norme si rinvengono nell’art. 85 del d.p.r. n. 3 del 1957 o nell’art. 15, co-4 octies della l. del 19 marzo 1990 n. 55 che sancivano la destituzione dei diritto del pubblico dipendente nel caso in questi riportasse condanne per taluni reati, tra cui quello di corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio previsto dall’art. 319 c.p. Di queste norme la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale proprio nella parte in cui non prevedevano che la pubblica amministrazione attivasse un procedimento disciplinare valutando l’incidenza dei fatti oggetto della sentenza sul rapporto di lavoro del pubblico dipendente. Sul tema, la Corte Costituzionale ha affermato l’esistenza di un contrasto con gli artt. 3 primo comma e 97 primo comma, della Costituzione nei casi di automatica cessazione del rapporto di lavoro senza che sia possibile valutare, adeguando la sanzione al caso specifico, la gravità del reato commesso, la rilevanza dello stesso in relazione all’attività svolta dal dipendente ed il vantaggio che la pubblica amministrazione possa avere dal suo mantenimento in servizio. In tal senso, la Corte Costituzionale, ha affermato un principio generale che in seguito è stato recepito ed applicato in molteplici pronunce sia di legittimità che di merito e formalmente recepito nella l. n. 97 del 2001 la quale all’art. 5, comma 4 prevede che <<Salvo quanto disposto dall’articolo 32-quinquies del codice penale (ossia condanna alla reclusione per un tempo non inferiore ai tre anni per i delitti di peculato ex art. 314 primo comma c.p.; concussione ex art. 317 c.p.; corruzione per l’esercizio della funzione ex art. 318 c.p.; corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio ex art. 319 c.p.; corruzione in atti giudiziari ex art. 319 ter; corruzione di una persona incaricata di pubblico servizio ex art. 320 c.p) nel caso sia pronunciata sentenza penale irrevocabile di condanna nei confronti dei dipendenti indicati nel comma 1 dell’articolo 3, ancorché a pena condizionalmente sospesa, l’estinzione del rapporto di lavoro o di impiego può essere pronunciata a seguito di procedimento disciplinare>>. La norma afferma quindi un vero e proprio obbligo in capo alla pubblica amministrazione di una riponderazione interna dei riflessi disciplinari delle sentenze penali, adeguandosi così, al principio generale dell’autonoma valenza dell’illecito disciplinare rispetto all’illecito penale. Pertanto, ne consegue che non tutti gli aspetti disciplinarmente rilevanti assumono valenza penale e viceversa. Nelle ipotesi di pronuncia di sentenza irrevocabile di condanna, il procedimento disciplinare deve avere inizio e deve concludersi entro centottanta giorni che decorrono dal termine di inizio o proseguimento, fermo quanto previsto dall’art. 653 c.p.p. (art. 5 comma 4, l. n. 97 del 2001, come modificato dall’art. 72, comma 2, d. lgs. 27 ottobre 2009, n. 150). Ed è proprio all’art. 653 c.p.p. che deve farsi riferimento per quanto riguarda l’efficacia della sentenza penale nel giudizio disciplinare. La norma al comma 1 bis, attribuisce alla sentenza penale irrevocabile di condanna efficacia di giudicato nel giudizio per la responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione dell’imputato che l’ha commesso. Sul punto la giurisprudenza (T.A.R. Lazio, sez. II, 1 marzo 2011 n. 1912; Consiglio di Stato, sez. IV, 26 gennaio 2009 n. 413) ha affermato che: <<A norma dell’art. 653 c.p.p., l’accertamento dei fatti oggetto del giudizio penale e del grado di partecipazione dell’impiegato ai fatti stessi, fa stato nel giudizio disciplinare quando debbano essere accertate le stesse circostanze e le stesse situazioni soggettive>>.Di conseguenza, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale (T.A.R. Lazio, sez. III, 14 giugno 2011 n.5285; Consiglio di Stato, sez. IV, 24 febbraio 2011 n.1203) i fatti compiutamente accertati in sede penale vanno assunti nel procedimento disciplinare senza che sugli stessi l’amministrazione possa procedere a nuovi separati accertamenti, dovendo procedere solo all’autonoma e discrezionale valutazione della loro rilevanza sotto il profilo disciplinare. Sono da ricondursi, al contesto giuridico appena illustrato, anche i casi di applicazione della pena su richiesta delle parti. Sul tema, prima della novella apportata agli artt. 445, co 1 e 653, co 1 bis c.p.p. dalla l. n. 97 del 2001, un consolidato orientamento della giurisprudenza (tra le diverse: Cons. St., sez. V, 6 giugno 2001, n. 3076; Cons. St., sez. IV, 23 maggio 2001, n. 2853; Cons. St., sez. VI, 23 febbraio 1999, n. 188) aveva affermato che ai fini dell’applicazione della sanzione disciplinare, doveva escludersi che i fatti riconosciuti dall’interessato a seguito a sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p., potessero assumere autonoma rilevanza anche in ambito disciplinare quale riconoscimento della responsabilità, essendo gli stessi privi di certezza legale. Così la pubblica amministrazione era obbligata a completare gli accertamenti effettuati in sede penale e a rivalutare gli stessi al fine di una sicura individuazione della responsabilità disciplinare del pubblico dipendente. Su tale orientamento giurisprudenziale in parte ha inciso la l. n. 97 del 2001, che nel modificare gli artt. 445 co. 1 e 653, co. 1 bis c.p.p., ha equiparato la sentenza emanata ai sensi dell’art. 444 c.p.p. a quella di condanna ai fini della sua rilevanza nel procedimento disciplinare. Così, attualmente, anche la sentenza di patteggiamento, analogamente ad altre sentenze di condanna, ha efficacia di giudicato nel giudizio di responsabilità penale davanti alle pubbliche autorità quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso. Va evidenziato come anche in questo caso per la pubblica amministrazione sia doveroso procedere ad un’autonoma in sede disciplinare della sentenza penale di condanna. Per quanto riguarda invece la sentenza penale irrevocabile di assoluzione ex art. 653 comma 1 c.p.p., va rilevato come essa abbia efficacia di giudicato nel giudizio di responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità, quanto all’accertamento che il fatto non sussiste o non costituisce reato ovvero l’imputato non l’ha commesso.
-
Pregiudizialità penale e sospensione cautelare
Un altro ambito da esaminare concernente il rapporto tra giudizio penale e procedimento disciplinare è quello che riguarda il principio della <<pregiudiziale penale>> sancito all’art. 117 del t.u. n. 3 del 1957 in base al quale <<Qualora per il fatto addebitato all’imputato sia stata iniziata azione penale, il procedimento disciplinare non può essere promosso fino al termine di quello penale, e se iniziato deve essere sospeso>>. Secondo la giurisprudenza (Cons. St., sez. IV del 28 gennaio 2011 n. 645) tale principio deve essere inteso nel senso che il dovere per la pubblica amministrazione di non dare inizio al procedimento disciplinare o di sospendere il procedimento già avviato nasce solo nel momento in cui viene esercitata l’azione penale (con gli atti tipizzati dal codice di procedura penale) e ciò anche quando i fatti suscettibili in astratto di costituire un reato sono ad essa rilevati e denunciati all’autorità giudiziaria. Secondo parte della dottrina questo principio, applicabile ai procedimenti che riguardano i dipendenti in regime di diritto pubblico, potrebbe essere applicato anche al procedimento disciplinare a carico dei docenti universitari. L’orientamento contrario sostiene invece che non è condivisibile la prospettata estensione ai docenti universitari di tale principio poiché essa non troverebbe giustificazione nella previsione normativa dell’art. 12, comma 2, della l. n. 311 del 1958 che, nel rinviare alle norme del t.u. 3 del 1957, richiama soltanto quelle che prevedono garanzie procedimentali nei confronti dell’incolpato (osservanza del principio del contraddittorio, audizione dell’interessato, contestazione dell’addebito).
Riguardo, invece, al provvedimento cautelare della sospensione non disciplinare, si rileva come esso possa essere adottato dal Rettore nei confronti del docenti universitari sia in pendenza di un procedimento disciplinare che in pendenza del procedimento penale. Nella prima ipotesi trova applicazione, in virtù del rinvio previsto dal primo comma dell’art. 12 della l. n. 311 del 1958 rubricata <<Norme sullo stato giuridico ed economico dei professori universitari>>, l’art. 90 r.d. n. 1952 del 1933 (Approvazione del testo unico delle leggi sull’istruzione superiore) secondo cui <<Ove la gravità dei fatti lo richieda, il Ministro può adottare a carico di un professore la sospensione dall’ufficio e dallo stipendio a tempo indeterminato, anche prima di conoscere le deduzioni dell’interessato, salvo regolare procedimento disciplinare>>. Nella seconda ipotesi, si deve invece far riferimento agli artt. 91 (sospensione cautelare obbligatoria), 96 (diritto alla restitutio in integrum nel caso in cui sia stata applicata una sanzione inferiore al periodo di sospensione cautelare sofferta o nell’ipotesi di proscioglimento in sede disciplinare), 97 (revoca della sospensione cautelare e diritto alla restitutio in integrum nel caso di sospensioni cautelari disposte in pendenza di procedimento penale) e 98 (sospensione della qualifica a seguito di condanna penale) del t.u. 3 del 1957, richiamati dall’art. 12, comma 2, della l. n. 11 del 1958 e alla normativa specifica applicabile a tutti i dipendenti pubblici. Bisogna distinguere le ipotesi in cui la sospensione dal servizio connessa alla pendenza di un giudizio penale sia disposta in base ad un obbligo di legge, quindi automatica, dai casi di sospensione in cui, pur essendo rimessa all’amministrazione il potere di disporre la misura cautelare, l’applicazione di questa derivi da una valutazione discrezionale dell’amministrazione. Nello specifico, l’art. 91 del t.u. 3 del 1957 prevede due distinte ipotesi di sospensione cautelare in pendenza del procedimento penale. Il primo caso è quello dell’ipotesi in cui il docente universitario sia destinatario di un mandato o di un ordine di cattura ed in questo caso, la pubblica amministrazione deve disporre immediatamente la sospensione dal servizio fino a quando permangano gli effetti del provvedimento restrittivo della libertà personale. Secondo la giurisprudenza (Consiglio di Stato, sez. IV, 08.11.2005 n. 6207; Consiglio di Stato, sez. IV,27.01.2003 n. 398; Consiglio diStato, sez. IV, 24.02.2003 n. 997), ai sensi dell’art. 91 comma 1, primo periodo del d.p.r. n. 3 del 1957, la sospensione cautelare dal servizio di un pubblico dipendente sottoposto procedimento penale, pertanto indagato e non imputato, può essere legittimamente disposta non solo quando lo stesso sia stato rinviato a giudizio, ma anche quando, in sede di indagini preliminari sia stata adottata una misura cautelare personale, ancorchè successivamente (sempre nella fase delle indagini preliminari) revocata o annullata. Nel diverso caso in cui, pur in assenza di misure cautelari personali, sia in corso un procedimento penale in capo al dipendente per reati di natura particolarmente grave, l’amministrazione può provvedere alla sospensione cautelare (si tratta dell’istituto della sospensione cautelare facoltativa prevista dall’art. 91, comma 1, del d.p.r. n. 3 del 1957). In questa ipotesi, la sospensione dura fino all’esito del procedimento penale, ma l’amministrazione può disporre la riammissione in servizio del docente universitario, anche nel corso del procedimento stesso. Si rileva, però, come una volta venuta a conoscenza della sentenza penale di condanna, l’amministrazione deve procedere alla sospensione cautelare nei casi previsti dall’art. 4 della l. n. 97 del 2001. La norma stabilisce che nel caso di condanna anche non definitiva ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, per taluno dei delitti previsti dall’art. 3, comma 1 (ovvero quelli di cui agli art. 314, primo comma, 317, 318, 319, 319 ter e 320 c.p. e art. 3 l. 9 dicembre 1941 n. 1383) i dipendenti indicati nello stesso articolo sono sospesi dal servizio. Si ritiene che la sospensione dal servizio per il caso previsto dall’art. 4 della l. n. 97 del 2001 abbia carattere propedeutico al procedimento disciplinare ed abbia ragion d’essere se questo venga successivamente instaurato ed iniziato nei termini di legge, non dubitandosi del fatto che essa sia obbligatoria. Le misure cautelari sono caratterizzate dall’assenza del carattere sanzionatorio in quanto si fondano su ratio e presupposti diversi da quelle che caratterizzano il procedimento disciplinare (Cons. Stato, Sez. IV, 18 settembre 2012). Inoltre, va evidenziato che l’art. 9, comma 2, della l. n. 19 del 1990 rubricata <<Modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti>> dispone che <<Quando vi sia stata la sospensione cautelare dal servizio a causa del procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo non superiore ad anni cinque>>.Infatti, con riferimento al termine di efficacia della sospensione cautelare, la Corte Costituzionale, con sentenza del 3 maggio 2002 n. 145, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 della l. n. 97 del 2001 proprio nella parte in cui disponeva che la sospensione perdesse efficacia decorso un periodo di tempo pari a quello della prescrizione del reato, individuando nel termine di cinque anni di cui all’art. 9 della l. n. 19 del 1990 l’espressione di <<Una vera e propria garanzia avente portata generale e dunque comprensiva, in difetto di diversa disciplina legislativa, di ogni e qualsiasi ipotesi di sospensione cautelare dal servizio a causa del procedimento penale, sia facoltativa che obbligatoria>>.Lo scopo della norma è quello di <<Contemperare le esigenze dell’amministrazione con quelle del pubblico dipendente, evitando che l’eccessiva durata del processo penale o l’interesse dell’amministrazione ad attendere il passaggio in giudicato della sentenza penale possa violare il principio di proporzionalità della misura cautelare.>> (T.A.R. Basilicata- Potenza, Sez. I, 9 luglio 2008 n. 984)4.
_
Note
1 Cfr. M.S. Giannini, “Autonomia (Saggio sui concetti di autonomia)”, Milano, Giuffrè, 1952, p. 345 e ss.
2 cfr. R. Morzenti Pellegrini, “L’autonomia universitaria”, 2018, Bologna, Bonomia University Press, p.151 e ss.
3 cfr. G. Santoro Passarelli, “Diritto dei lavori e dell’occupazione”, 2019, Torino, Giappichelli editore, p. 485 e ss.
4 cfr. M. Capece “Le regole del procedimento disciplinare dei docenti universitari dopo la legge 30 dicembre 2010 n. 240”,www.amministrativamente.com fascicolo n. 1/2012, p. 1 e ss.