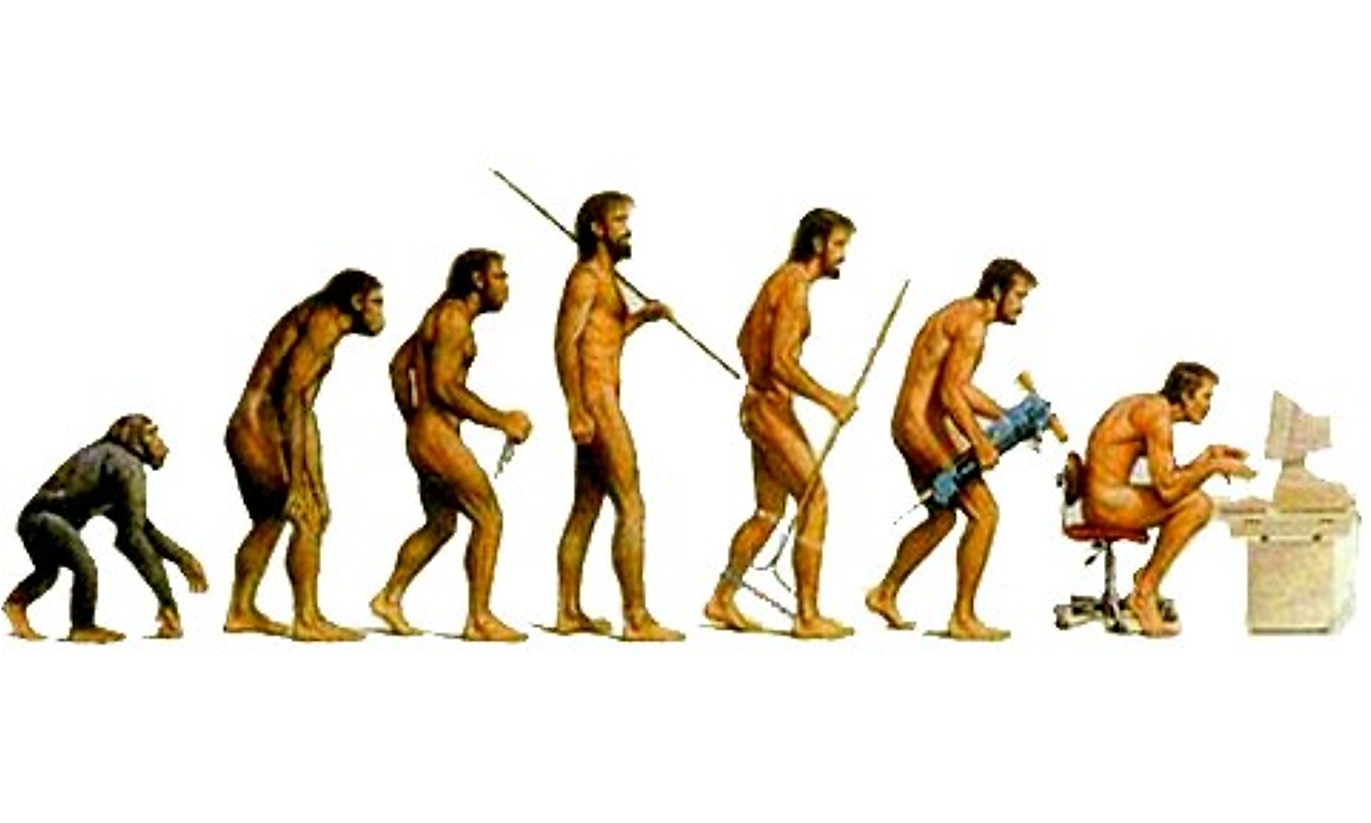di Marco Ferrari
- Colamedici A., Gancitano M., Ma chi me lo fa fare? Come il lavoro ci ha illuso: la fine dell’incantesimo, HarperCollins, Milano 2023, 248 pp.
Il tema del rapporto tra lavoro e tempo di vita, inteso sia come uso delle ore scandito dai ritmi produttivi, sia come qualità della vita stessa, sta acquistando un’importanza sempre maggiore nel dibattito culturale europeo e americano: dal quiet quitting ai bullshit jobs, dall’etica del lavoro all’assenza di limiti nello smart working, così come a molte altre manifestazioni del disagio lavorativo ed esistenziale, la riflessione su quanto valga il proprio tempo e come lo si impieghi (principalmente per produrre senza sosta) è, ormai, una riflessione sulla natura degenerante della vita associata. Il libro di Maura Gancitano e Andrea Colamedici, filosofi fondatori del progetto Tlon, affronta tale riflessione da diverse prospettive, dando un quadro esauriente di ciò che il lavoro sia diventato nelle nostre vite: da mezzo di sussistenza a valore morale, elevato a metro di giudizio della persona e della collettività, configurato attraverso prassi e ritmi vieppiù disumani, fino a trasformarsi in una sostanziale tortura di massa, fisica e psicologica.
 Il saggio, da poco uscito per i tipi di HarperCollins, riprende e approfondisce riflessioni iniziate in lavori precedenti della coppia, in particolare il seminale La società della performance, nonché, per altri versi, L’alba dei nuovi dèi e anche Prendila con filosofia (in quest’ultimo attraverso una struttura non lineare). Un percorso di riflessione critica che in Ma chi me lo fa fare? trova un approdo dal punto di vista del lavoro, o meglio ancora del «lavorismo» come ideologia e prassi, ossia dei rapporti di produzione come tessuto fondamentale dei rapporti umani. L’analisi, ben lontana da pedanterie e verbosità, scorre su visioni storiche ed evolutive dell’idea di lavoro come intreccio etico e mistico, necessario alla produzione di opere e beni fino alla coercizione di larghe fasce della popolazione, ma inteso come fonte di valore per la persona, oltre che per le merci. La storia umana è marcata dallo sfruttamento di milioni di vite per la produzione di un benessere fruito da pochi, dalle prime forme di schiavitù alle moderne divisioni di classe, fino all’attuale illusione dell’auto-realizzazione attraverso il sacrificio, la disciplina e l’ambizione, tipica della cultura neoliberista. Un’illusione etica, in quanto il lavoro nobilita, addirittura rende liberi – di conseguenza, qualsiasi altra attività che non sia produttiva è una perdita di tempo, un disvalore da disprezzare.
Il saggio, da poco uscito per i tipi di HarperCollins, riprende e approfondisce riflessioni iniziate in lavori precedenti della coppia, in particolare il seminale La società della performance, nonché, per altri versi, L’alba dei nuovi dèi e anche Prendila con filosofia (in quest’ultimo attraverso una struttura non lineare). Un percorso di riflessione critica che in Ma chi me lo fa fare? trova un approdo dal punto di vista del lavoro, o meglio ancora del «lavorismo» come ideologia e prassi, ossia dei rapporti di produzione come tessuto fondamentale dei rapporti umani. L’analisi, ben lontana da pedanterie e verbosità, scorre su visioni storiche ed evolutive dell’idea di lavoro come intreccio etico e mistico, necessario alla produzione di opere e beni fino alla coercizione di larghe fasce della popolazione, ma inteso come fonte di valore per la persona, oltre che per le merci. La storia umana è marcata dallo sfruttamento di milioni di vite per la produzione di un benessere fruito da pochi, dalle prime forme di schiavitù alle moderne divisioni di classe, fino all’attuale illusione dell’auto-realizzazione attraverso il sacrificio, la disciplina e l’ambizione, tipica della cultura neoliberista. Un’illusione etica, in quanto il lavoro nobilita, addirittura rende liberi – di conseguenza, qualsiasi altra attività che non sia produttiva è una perdita di tempo, un disvalore da disprezzare.
Devi renderti perennemente visibile, farti vedere indaffarato dai colleghi o dal pubblico, occupato in un’attività lavorativa di qualunque tipo; tutto, purché il tuo non sia soltanto ozio. Solo se sei pieno di lavoro allora sei importante e meriti il riconoscimento altrui. (p. 38-39)
L’opposizione tra otium e negotium è ormai risolta a favore del secondo, riversando sul primo la responsabilità dell’inefficienza e della povertà. Quindi, l’ozio, il tempo libero e improduttivo, è caratteristico dei fannulloni: chi lavora e produce deve mostrarsi sempre impegnato in qualcosa, tanto per non essere giudicato male dagli altri, quanto e forse soprattutto per non soffrire di sensi di colpa. Se non altro, perché nella mistica del lavoro rientra la colpa soggettiva dell’insuccesso: se tu sei l’artefice unico del tuo destino, secondo l’idea che se vuoi puoi farcela, allora anche il fallimento è solo colpa tua, della tua inazione e della tua irresponsabilità nel non impegnarti abbastanza; laddove elementi oggettivi come le condizioni di partenza, la provenienza di classe e di territorio, le caratteristiche personali e ogni altro problema sociale, sistemico e discriminatorio-intersezionale, diventano mere scuse per la propria pigrizia. Perché, come disse Margareth Thatcher nel 1987, «there’s no such thing as society». Non esiste la società, esistono individui, che devono pensare a se stessi innanzitutto. Ciò stimola diverse riflessioni, che provo a sintetizzare rifacendomi ad alcuni dei molti e fecondi punti del libro.
Un tempo “liberato”?
Dall’inizio del secolo si assiste a una costante fluidificazione della vita associata, una modernità liquida, per usare le parole di Bauman, in cui non c’è più terreno comune su cui sostare, ma solo precarietà e incertezza che costringono a muoversi sempre, a rinnovarsi nelle competenze, nelle conoscenze e nei valori. Lavoratori e lavoratrici del Duemila devono essere multitasking, adattabili, flessibili, riorientabili; capaci di cambiare lavoro, mansione e carico operativo a seconda delle esigenze, pur di mantenersi appetibili in azienda e ancor di più sul mercato. Ciò, come è intuibile, a favore della produttività e a scapito della vita privata, sempre più invasa dalla reperibilità, favorita dalla tecnologia. Ma, riflettono Gancitano e Colamedici, non doveva essere proprio lo sviluppo tecnologico a ridurre il carico e l’orario di lavoro, come auspicava Keynes? In realtà, la scansione del tempo è mutata in ogni era a seconda del rapporto di produzione dominante.
Nel tempo agricolo, i ritmi di lavoro erano legati a quelli naturali: alternanza delle stagioni, ciclo delle semine, ritmi circadiani (ci si alzava all’alba, si lavorava fino al tramonto), selezione dei giorni di lavoro e di pausa, cambio delle attività nell’attesa e via dicendo. Con la rivoluzione industriale, il ritmo diventa quello delle macchine e della produzione in serie: l’orario di inizio e di fine è lo stesso per tutti, le attività sono ripetitive e sempre uguali ogni giorno, non contano più fattori esterni come le condizioni meteorologiche, mentre tutta la società si struttura attorno a un modello unico di tempo. Nella società attuale, che fino a poco tempo fa si definiva postmoderna, il tempo e la produzione seguono una scansione flessibile: se alcuni impianti arrivano a lavorare anche 24 ore su 24, il settore industriale ha perso progressivamente spazio in favore di quello dei servizi che, grazie all’innovazione e alla pervasività delle tecnologie della comunicazione e dell’informazione, non ha necessità di ridefinire gli orari di lavoro su cui strutturare la vita sociale e individuale. Semplicemente, il tempo del lavoro e il tempo libero si sovrappongono fino a coincidere. La speranza di un tempo “liberato” nel senso di lavorare meno e riappropriarsi di uno spazio personale affettivo, è svanita nella realtà di un tempo “liberato” da vincoli e limiti nei confronti dell’esistenza individuale e collettiva.
La genesi di nuove forme di sfruttamento, basate sulla perenne rintracciabilità fuori dai luoghi fisici di lavoro, passano anche attraverso formule ideologiche di rivalorizzazione dell’azienda come “famiglia”, gruppo emotivo di produzione anche valoriale, cui dedicare stoicamente la propria vita interiore, in nome della mission quale scopo degno di essere perseguito. Una tale dedizione riecheggia lo sfruttamento tipico del lavoro ottocentesco, di sicuro ne riprende la precarietà e la prevaricazione, ma ammantate dalla convinzione che non ci sia alternativa, e neppure sia bene volerla. Ma c’è da dire, come pure sottolineano l’autrice e l’autore, che almeno nella società industriale dell’Ottocento si era compreso quanto necessario fosse concedere un po’ di riposo. Nel modello attuale, la dedizione illimitata vede persino nel sonno un nemico; famosa a tal proposito l’affermazione del CEO di Netflix, ma anche il consiglio, tra il serio e il faceto, di Schwarzenegger a chi dice di non poter dormire sei ore anziché otto: «sleep faster». A questo punto, il burnout è dietro l’angolo.
Workaholic alla riscossa
Fortissima è la sensazione di essere tutti “figli” degli anni Ottanta, non tanto per ragioni anagrafiche, quanto per l’inestinguibile fame e follia delle forme capitalistiche attuali, che nella promessa di ricchezza e benessere per tutti continuano la tradizione degli yuppies, con il loro ardore che brucia tutto ciò che ama. Ed è questo amore bruciante, fatto d’ambizione, conquista, auto-realizzazione attraverso il successo, a far aumentare ancor di più i ritmi di lavoro, a sottomettere ogni aspetto della quotidianità alla produzione, proponendo tale prospettiva non solo come necessaria, ma come desiderabile, in modo da amare il proprio lavoro e il sacrificio che comporta. Un amore più simile a una dipendenza, che intossica alcuni e trascina con sé tutti gli altri: il workaholism, la dipendenza da lavoro paragonata all’alcolismo, in quanto solo l’attività lavorativa riempie di senso e gioia le giornate. I grandi nomi del capitalismo di ventura, gli uomini più ricchi del mondo, sono workaholic e pretendono dai loro dipendenti la stessa passione (tanto nel senso di amore, quanto di sofferenza): basti pensare ai comunicati di Elon Musk ai suoi nuovi sottoposti, ogni qualvolta fonda o acquisice una azienda o una società, da Tesla a Twitter, in cui chiede di dedicarsi in maniera straordinaria e totale alla causa – la sua causa – in cambio di straordinari premi, o per converso di subitanee esclusioni.
Tutto ciò non sarebbe possibile senza una rivalsa storica della cultura del successo. Dopo secoli di moralismo cattolico contro l’accumulo di ricchezza, di pretese socialiste di redistribuzione di quanto prodotto da alcuni per tutti, persino di grande positività protestante rispetto al lavoro, ma nella prospettiva spirituale del successo come prova divina del giusto percorso (io semplifico, su quest’ultimo punto la disamina di Colamedici e Gancitano è molto più approfondita e complessa, riprendendo Weber e altri autori), oggi gli eredi dell’edonismo degli anni Ottanta ribaltano il tavolo da gioco e pongono il successo lavorativo come vero valore, vero piacere e vero scopo della vita, da ostentare con orgoglio. Libri, videocorsi, astruse elaborazioni solipsistiche (dal «pensiero positivo» alla «legge dell’attrazione»), propagandano in tutti i modi il sogno di potercela fare, con le proprie forze e la propria passione, con il proprio sacrificio in ogni momento, un sogno alla portata di tutti, a patto di amare ciò che si fa. E per amarlo, basta accettarlo in tutto e per tutto, senza critiche né riserve; torna alla mente la figura della madre in Goodbye, Lenin! la quale, non potendo fuggire dalla DDR, sceglie di dedicarvisi anima e corpo, diventandone una fervente servitrice.
Nel caso del «lavorismo», però, questo meccanismo non si basa tanto sulla coercizione, quanto sulla convinzione che il gioco valga la candela, poiché se è alla portata di tutti, allora ciò che conta è focalizzare l’attenzione su chi effettivamente vince, distogliendola dalla condizione delle moltitudini che invece non ce la fanno, evitando di pensare che sia quest’ultima la normalità, anziché l’eccezione dovuta alla fannulloneria e all’incapacità. E questo rende amabile e desiderabile persino un lavoro che, di per sé, non ricambierà mai l’amore dato, ma ne pretenderà sempre di più in cambio di sforzi disumani e misere ricompense. Una condizione simile peraltro alla cosiddetta sindrome di Stoccolma, dove i prigionieri finiscono per prendere le parti dei loro rapitori. Non importa, insomma, se questo genere di produttività tenda a lasciare da parte, senza esitazioni, chiunque non sia in grado di seguirne il ritmo e il carico; è ormai scontato che il mondo debba funzionare così e qualunque critica agli spiriti animali del capitalismo è derubricata a lamentela da gente viziata e pigra.
Il valore reale del lavoro
In tutto il libro, la critica alla negatività del modello lavorativo dominante, il lavorismo come ideologia e come prassi, potrebbe indurre a credere che l’opposizione sia rivolta al lavoro in sé, come esperienza umana. Non è così. Gancitano e Colamedici, non fornendo le classiche ricette per una vita felice senza il lavoro, tentano di recuperare semmai il valore reale del lavoro nella sua accezione più umana, di produzione per un benessere che non risiede nel successo a tutti i costi, ma nella creazione delle condizioni di vita dignitose, atte alla fioritura personale e collettiva. Una visione del lavoro come partecipazione ed emancipazione dalla schiavitù del lavoro stesso, di cui il lavorismo è la distorsione drammatica che schiaccia quegli stessi individui cui promette libertà.
Un punto fondamentale dell’analisi del lavoro riguarda le motivazioni profonde che portano a lavorare. La necessità di produrre di più, di dedicare sempre più tempo al lavoro e sempre meno al resto, non può essere giustificata solo dalla volontà di fare più soldi, accumulare più capitali, come fine in sé. Molte persone sono alla ricerca di un significato da implementare nella loro vita e, se il lavoro è divenuto un modello etico, allora esso deve avere una sua produzione di senso per chi lo svolge. La sensazione di sprecare il proprio tempo colpisce in particolare chi svolge un incarico di cui non trova il significato per la propria vita e per la società; in alcuni casi, anche un lavoro regolarmente remunerato può frustrare la persona, per la mancanza di senso che esso comporta. Si può richiamare qui il simbolismo di Momo, il romanzo di Michael Ende, in cui la bambina che sa ascoltare deve affrontare i Signori Grigi con la loro Banca di risparmio del tempo, grazie a cui in realtà sottraggono tempo alle persone per un “uso futuro”: quale potrà essere questo uso futuro, mentre la quotidianità è compressa e pervasa senza soluzione di continuità? Manca l’ascolto, il tempo dedicato a se stessi e agli altri, così come manca il senso del lavoro, sempre rimandato al futuro.
L’invito che, infine, l’autore e l’autrice rivolgono al pubblico, è di riempire di senso la propria vita attraverso la partecipazione alla cosa pubblica, trasformando il lavoro in un campo dell’agire nel senso che ne dava Arendt in Vita activa. Lavorare non per trovare un senso di realizzazione personale tra un obiettivo e un progetto, arrivando alla fine senza averlo scovato; bensì lavorare per costruire insieme un senso delle cose, creare e ricreare non solo merci, ma relazioni, vita associata, dialogo e cultura.
Sia concesso allora chiudere con una famosa citazione di Marx, tratta dai Manoscritti economico-filosofici del 1844:
L’economia politica è quindi, nonostante il suo aspetto mondano e lussurioso, una scienza realmente morale, la più morale di tutte le scienze. La rinuncia a se stessi, la rinuncia alla vita e a tutti i bisogni umani, è il suo dogma principale. Quanto meno mangi, bevi, compri libri, vai a teatro, al ballo e all’osteria, quanto meno pensi, ami, fai teorie, canti, dipingi, verseggi, ecc., tanto più risparmi, tanto più grande diventa il tuo tesoro, che né i tarli né la polvere possono consumare, il tuo capitale. Quanto meno tu sei, quanto meno realizzi la tua vita, tanto più hai; quanto più grande è la tua vita alienata, tanto più accumuli del tuo essere estraniato. (“Bisogno, produzione e divisione del lavoro”, XV)
*
Libri di Maura Gancitano e Andrea Colamedici
- Tu non sei Dio. Fenomenologia della spiritualità contemporanea, Tlon, 2016
- Lezioni di meraviglia, Tlon, 2017
- La società della performance. Come uscire dalla caverna, Tlon, 2018
- Liberati della brava bambina. Otto storie per fiorire, HarperCollins Italia, 2019
- Prendila con filosofia. Manuale di fioritura personale, HarperCollins Italia, 2021
- L’ alba dei nuovi dei. Da Platone ai big data, Mondadori, 2021
- Ma chi me lo fa fare? Come il lavoro ci ha illuso: la fine dell’incantesimo, HarperCollins Italia, 2023